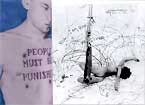|
Siro Ferrone
Se si fa riferimento alla produzione Beckettiana contemporanea all'esistenzialismo
(Porte chiuse di Sartre e Alta sorveglianza di Genet) e penso a -Finale
di partita- mi pare che ci sia un gioco a smontare parodisticamente
queste strutture drammaturgiche a cui si credeva profondamente nella
società francese del tempo, giocando su questi punti di partenza
proprio per dissociarsi e quindi - parodia - in senso più alto
(come la retorica della parodia) per poi prendere una strada variegata
e complessa.
Ed anche a questo riguardo -nella composizione mnemonica, l'esercizio
sulla devastazione della memoria nella quale
( questo è un punto
che mi fa pensare che il teatro sia al centro di tutto)
l'elemento chimico cerebrale è importante
e quindi l'attore è importante. Cioè la gestione della falla
della memoria, il disorientamento ed il precipitare della ragione in una
serie di catastrofi progressive appartengono molto, mi pare, alla condizione
del performer, di colui che non si limita a vivere questa cosa concettualmente,
ma in qualche modo è tenuto a esporla ad altri - e cioè la
vive non solo con la testa e la mente, ma la vive pienamente con il corpo.
Una specie di delega all'attore, più di chiunque altra realtà,
della propria malattia, della propria patologia memoriale.
La gestione del disorientamento della ragione è diverso se è concepita
dallo scrittore - o se invece è concepita dal corpo presente dell'attore.
Cesare Molinari
La battuta chiave per interpretare questo concetto di parodia è quello
di Nagg in -Finale di partita-
"
Niente è più ridicolo del
dolore" dice.
Giancarlo Cauteruccio
Ho sempre immaginato Beckett prima di scrivere -Aspettando Godot- e di
Beckett che non era mai entrato in Teatro, come succede a scrittori
ed architetti e a molti pittori.
Allora cosa è successo in Beckett, osservatore attento, ma che
si lasciava sorprendere dalle cose.
Lui ha colto (così come lo si evince da quello che lui scrive)
per esempio - Atto senza parole -
la complessità della macchineria teatrale.
( graticcia, corde, nodi delle corde, blocco dele corde...)
Altro esempio, potete immaginare il magnetofono del 1957! Il magnetofono
nel 1957 era sicuramente uno strumento di altissima tecnologia. Non solo
per quello che era tenuto a fare, ma per il fatto che è il primo
strumento in assoluto che riusciva a catturare - il qui ed ora - e trasferirlo
in tempo reale su base magnetica - per cui ritornando indietro si poteva
riascoltare la propria voce.
E tutto questo nel 57 quando la televisione era appena nata.
Questo era uno strumento di alta tecnologia - e Beckett ha capito subito
quando ha scoperto questo strumento che da lì si apriva tutto
il conflitto che si sarebbe generato tra l'uomo e la macchina nella seconda
metà del novecento.
Quando poi ha scritto -Atto senza parole- al di la della scelta lirica
(affascinato forse da un
mimo in particolare ) lui è rimasto affascinato dalla macchineria,
di poter far scendere e salire gli oggetti magicamente - di poter far
uscire ed entrare in scena un corpo, ed è esattamente quello che
succede in - Atto senza parole - un esercizio preciso di uso della macchina
scenica, e se voi ci fate caso - è un esercizio scientifico di
come si usa, e quali sono le potenzialità di
una macchina scenica.
Ecco perchè preferiva lavorare con i grandi attori, perchè lui
prendeva l'attore come un elemento già pronto per essere messo
in uso. Non che gli interessasse il processo attraverso il quale l'attore
arrivava a mettere in scena il testo.
Quando lui rimane solo scrittore allora scatta la necessità di
farlo proprio... altrimenti diventa irrappresentabile.
Così come le questioni del tempo in -Giorni felici- le questioni
della malattia e la corrosione della materia - della malattia della luce,
sono tematiche che lui riporta nella sua scrittura, ma che cattura con
grande sensibilità dal reale.
Ecco perchè credo sia importante fare un percorso di vita e arte...
per leggere Beckett come merita di essere letto.
Siro Ferrone. Professore ordinario. Discipline dello
spettacolo a Firenze. Direttore di “Drammaturgia”. magazine
online di cultura dello spettacolo.
Cesare Molinari è ordinario di Storia del teatro e dello spettacolo
presso la facoltà di Lettere dell'Università di Firenze
e direttore del Dipartimento di Storia delle arti e dello spettacolo.
Dal 1971 dirige con Ferruccio Marotti la rivista «Biblioteca Teatrale».
Fra le sue pubblicazioni: Le Nozze degli dèi (Roma 1968)
Giancarlo Cauteruccio regista-scenografo-artista visivo
della compagnia Krypton. Direttore Teatro Sudio Scandicci.Tra le produzioni
recenti - Ubu c’è,
2004- e la regia - Bang Bang/in Care - Filottete e l’infinito rotondo,
2004.
|